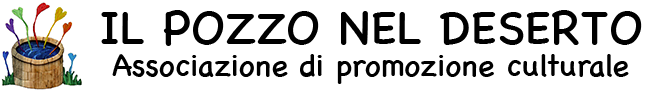Mettere per iscritto i sogni non è mai cosa semplice perché significa nutrire la profonda speranza che essi si realizzeranno. Descriverli è un po’ rovinarli, toglierli alla loro perfezione per far sì che ne acquistino una nuova – più fragile ma ancor più bella -, quella che può esserci soltanto entrando nella realtà. Queste brevi righe vogliono quindi dare un po’ di voce ad un sogno, perché questo possa, con la forza di un leone e la pazienza di una formica, acquisire un po’ di realtà.
La strada da percorrere assomiglia ad uno stretto sentiero di montagna, impervio e faticoso, che corre fra rocce e stradine fangose, e che a tratti si allarga, trova punti panoramici mozzafiato, si infittisce nei boschi, si stupisce di rigoli d’acqua, si inciampa in radici e pietre sconnesse. Un sentiero che non ha l’ambizione di diventare una strada asfaltata e non vuole esserlo se questo vuol dire rinunciare alla vista di cui si gode dalla cima del monte. Come ogni cammino anche questo ha delle tappe: una preoccupazione, che a tratti diviene paura angosciante, una speranza, che anima e muove ricordandoci la direzione, un sogno, che contemporaneamente si costruisce e ci nutre.
La preoccupazione che ci muove sorge da un sentimento di smarrimento vissuto davanti ad una società che sembra non avere più la forza di accogliere in sé la vita dell’uomo e della donna che aspirano, naturalmente, ad essere pienamente se stessi. Sembra di essere vittime di un incantesimo, che però di magico ha ben poco, capace di trasformare i nostri desideri più profondi in semplici appetiti, la nostra speranza in aspettative e la nostra vita in semplice esistenza.
In molti fra poeti, romanzieri, filosofi e artisti hanno con sofferenza denunciato la barbarie di un mondo che, dimentico di sé e della sua bellezza possibile, non fa altro che ripetere schemi in cui l’essere umano è ridotto a rotella di un ingranaggio che lo rende schiavo e spesso cieco verso la sua stessa sudditanza. Una voce autorevole in tal senso è quella di Ivan Ilich – scrittore, storico, pedagogista e filosofo austriaco – che con insistenza e fermezza mostra come il mito del progresso e dello sviluppo senza limite abbia rapidamente invaso la nostra vita infilandosi in ogni suo aspetto. Il lavoro, la sanità, la scuola, la vita quotidiana, risentono pesantemente di questo processo che sostituisce la macchina all’uomo, invertendo il rapporto essere umano-strumento: gli oggetti non sono più strumenti utili all’uomo che può costruirli, utilizzarli e distruggerli, ma diventano per lui indispensabili al punto da renderlo schiavo. E’ chiaro che una simile percezione è artificialmente costruita, ma si è così radicalmente affermata da essere percepita ormai come naturale. Ciò implica una sudditanza nei confronti degli strumenti, che solo raramente è vissuta come ingiusta o pericolosa: per lo più si crede che sia il prezzo da pagare per una vita migliore, cioè più lunga e soddisfacente. La coincidenza fra progresso e bene risulta evidente: si crede cioè che tutto ciò che porta ad un aumento della produttività e dell’efficienza, quindi della velocità e della durata – prima fra tutte quella della vita – sia buono a prescindere.
Oggi, attraversato quel XX secolo in cui Illich vive e di cui denuncia le dinamiche di oppressione, non possiamo che constatare che tale processo non soltanto non si è arrestato ma assume connotati ancor più oscuri, sia perché meno visibili, sia perché più insidiosi. Il mito del progresso si è modernizzato e viene chiamato crescita, ma la parola nasconde soltanto la volontà di rendere il mondo un immenso ingranaggio di produzione in cui la vita umana ha valore soltanto nella misura in cui diventa olio per questo meccanismo presentato come infallibile.
In tale dimensione uomini e donne vengono ubriacati con la pubblicità del successo, che riduce il desiderio umano, sorgente di creatività, novità, invenzione, a appetito da saziare il più velocemente possibile. Questo è vero tanto nella vita dei singoli quanto in quella delle comunità: ciascuno procede individualmente e ogni progetto comune è contaminato dall’arrivismo e dalla prevaricazione sociale. Mentre crediamo di realizzare la nostra vita in realtà non facciamo altro che darla in pasto ad una potenza sconosciuta che si disinteressa completamente di noi e della nostra felicità. Di qui il bisogno di prolungare la vita il più possibile, necessità che sorge in realtà da un vuoto di senso che, se avvertito, denuncia l’inutilità di una esistenza sprecata.
Così brevemente delineata la situazione della nostra epoca sembra quantomeno disperata, ma non è certo alla disperazione e all’angoscia che vogliamo arrenderci. In tale orizzonte il primo rischio da evitare è infatti quello di cedere all’illusione di un destino cieco che ci renderebbe schiavi e impotenti – visione tanto tragica quanto rassicurante -. Maria Zambrano, filosofa spagnola del Novecento, con un paradossale gioco di parole ricorda[1] che il destino fatale diventa cieco soltanto quando è negata la speranza che esso custodisce, cioè quando il destino luminoso presente in forma embrionale non trova la via della realtà e rimane nella storia come una musica che nessuno ha mai suonato. Il tempo può scorrere senza che nulla accada veramente, senza che ci sia storia: l’uomo può continuare ad esistere, magari sempre più a lungo, senza però vivere neppure un secondo della sua vita.
E’ proprio su questo punto che si giocano la nostra speranza e il nostro sogno. Una speranza che, tutt’altro che ingenuamente, nasce da un esempio e da una convinzione. L’esempio viene da tutte quelle esperienze che denunciano l’oblio del senso della vita del singolo e dell’intera comunità umana; la convinzione, ad esse legata, è nutrita dall’amore profondo per l’essere umano che mostra di essere origine di novità, creazione, trasformazione. Quello che si vuol mostrare è che il destino che l’essere umano vive oggi può essere invertito, che la sua storia può essere un’altra, e che sperare in tale direzione non è ingenuo o utopistico ma è segno di responsabilità nei confronti di una umanità dimentica del suo futuro.
E’ chiaro che simile visione nasce da una preciso sguardo antropologico che ci sembra essere fedele al nucleo di senso profondo della vita umana. L’idea che ci guida è che il vero nemico della vita non sia la morte fisica, da sfuggire e allontanare il più possibile, ma quella morte ancora più radicale che coincide con l’aver sprecato la propria esistenza. Maria Zambrano scrive che “si può morire pur rimanendo vivi; si muore in molti modi: in certe malattie, nella morte del prossimo e, ancor di più, nella morte di ciò che si ama e nella solitudine prodotta dalla totale incomprensione, dall’assenza di possibilità di confessarsi, quando a nessuno possiamo raccontare la nostra storia”[2].
Si tratta di scoprire che l’uomo e la donna non si trovano nel mondo soltanto per esaurire il tempo che hanno a disposizione ma per viverlo in modo da fare della loro esistenza un cammino di nascita.
In tale orizzonte sembra coerente e vero seguire la filosofa spagnola nella descrizione dell’uomo come un essere nascente: tutti condividiamo l’esperienza di una prima nascita, quella biologica, ma è possibile per ciascuno affrontare nuove nascite che conducano ad essere veramente se stessi, ad esprimere pienamente chi possiamo essere. Sarebbe ingenuo credere che un simile percorso sia certo e predeterminato: è la vita stessa ad insegnarci la forza del tragico che permea e continuamente insidia il nostro cammino. Ma occorre riconoscere che, nonostante la morte, la sofferenza, la schiavitù diretta o indiretta, le forme di oppressione, il nostro senso di impotenza e inutilità, possiamo essere diversamente.
Ciò significa anzitutto riappropriarsi del tempo e viverlo come alleato, trasformando l’avvenire che ci hanno insegnato in futuro vero, cioè un tempo nuovo in cui possa sorgere qualcosa di radicalmente altro.
E’ qui che si instilla il sogno che vorremmo acquisti realtà. Nessuna speranza si nutre senza un sogno che sappia suscitare azioni, guidare scelte, proporre rischi: esso è da intendersi non tanto come un’immagine cui avvicinarsi, ma come una guida e un progetto. La guida suggerisce la saggezza di un uomo colto, la pazienza di un insegnante, l’amore di una madre o un padre, la forza di un amico, la dolcezza dei nonni; è tutto ciò che ci sostiene e conduce costruendo con noi la nostra strada. D’altra parte è progetto, simile allo schizzo che un pittore fa sulla tela. Non è nulla di definito una volta per tutte e la sua imprecisione non è un limite, ma la traccia e l’orizzonte di qualcosa che soltanto attraverso di noi può nascere pienamente.
Il sogno che ci guida e che con noi cresce è quello di una società giusta e libera, capace anzitutto di prendersi cura della vita che in essa si dischiude. Una realtà che sappia accogliere l’uomo nella sua interezza, con le sue fragilità, i suoi dolori, la sua speranza di scappare alla morte, la sua voglia di essere veramente se stesso.
Il sogno di cui parliamo racchiude la certezza che un altro modo di esistere sia possibile, che l’umanità intera condivide un destino di luce che non ha ancora scoperto, e che ognuno di noi può lavorare affinché questa realtà fiorisca. Nutriamo la profonda speranza che questo sogno, sorgendo nel cuore della nostra esperienza, ci renda abbastanza forti da non arrenderci alle sue sfide e abbastanza liberi da stravolgere ogni giorno i nostri piani.
D’altro canto, se quanto detto fin qui ha qualche valore, la più grande speranza è che questo sogno non appartenga mai veramente a nessuno per poter appartenere a tutti. Scrive Zambrano: “la storia è sogno, il sogno dell’uomo […] risvegliarsi, senza smettere di sognarsi, è come avere un sogno lucido”[3]; educarci a rispondere al sogno che da sempre siamo è la vera sfida: riconoscerlo e con tutte le forze abbandonarci ad esso.
[1] Cfr Delirio y Destino, Mondadori, Madrid 1989, tr.it. di R. Prezzo e S. Marcellini, Delirio e Destino, Raffaello Cortina editore, Milano 2000, p.235. La fatalità è, paradossalmente, qualcosa di evitabile, qualcosa a cui si può porre rimedio, con e nella storia, rispondendo alla chiamata della speranza, lasciando che essa si manifesti in tutta la sua pienezza. Quando però ciò non accade e la speranza si smarrisce in cerca della sua casa, allora subentra il destino cieco, l’orizzonte di ciò che è ormai inevitabile.
[2] M. Zambrano, Delirio e Destino, p. 16.
[3] M. Zambrano, Delirio e Destino, p. 65.